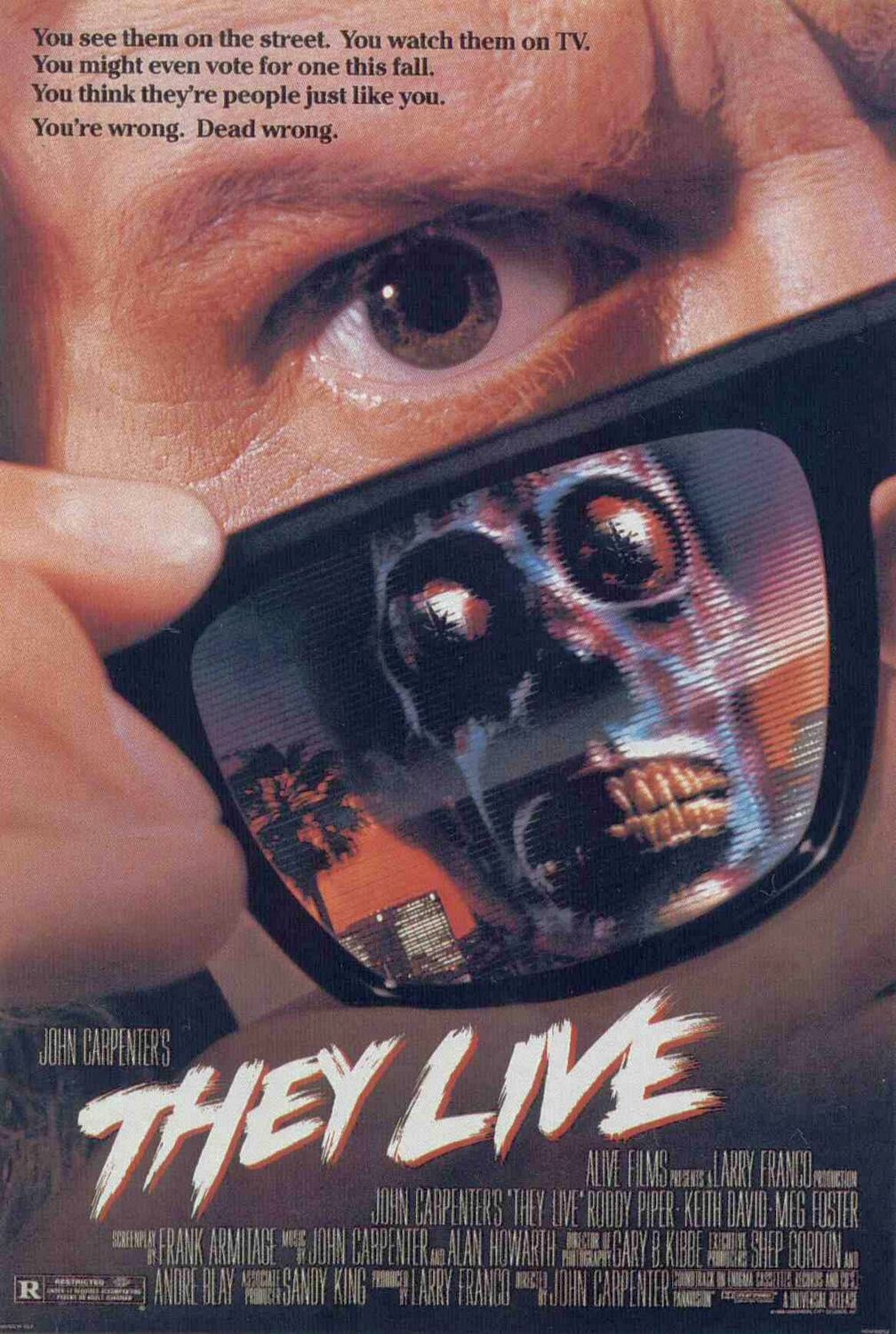Tusk (USA/Canada, 2014)
di Kevin Smith
con Justin Long, Michael Parks, Haley Joel Osment, Johnny Depp, Genesis Rodriguez
Circa sette anni fa, ormai quasi otto, Kevin Smith e il suo amico per la pelle Scott Mosier scoprono di potersi divertire un sacco nel fantastico mondo dei podcast e iniziano a registrare ogni settimana un'ora di chiacchiere più o meno sceme sul tema "Boh, quel che ci interessa questa settimana". Una volta elargito a un mondo che non aspettava altro, il risultato di quelle chiacchierate, che si chiama
SModcast perché i nomi dei podcast tendono a venir fuori così, riscuote un successone tale da diventare la base per un discreto business. Se da un lato infatti è noto che anche se ti chiami Kevin Smith e il tuo podcast lo scarica chiunque, i soldi non ce li fai lo stesso, dall'altro puoi trasformare il tutto in uno strumento tramite cui creare (o, se ti chiami Kevin Smith, consolidare) una fanbase che poi ti compra il libro, ti paga il biglietto per l'evento live e ti spinge a dirigere un film cretino che, pur incassando pochissimo, finisce per fare da trampolino per il rilancio della tua carriera da regista. E insomma, alla fine giusto così, no? Boh.
Comunque,
Tusk nasce per l'appunto da SModcast, per la precisione dal duecentocinquantanovesimo episodio, nel quale Smith e Mosier si trovano a chiacchierare di un'inserzione pubblicitaria (poi rivelatasi finta) apparsa su
Gumtree, in cui un tizio offre alloggio gratuito a chiunque sia disposto a travestirsi da tricheco. Dopo aver trascorso un'ora sparando cretinate col suo amichetto su un'ipotetica storia ispirata a quell'inserzione, Smith chiede a Twitter di fargli sapere se sia il caso di mettere in produzione un film del genere. #WalrusYes o #WalrusNo? Domanda retorica. Circa un anno dopo,
Tusk arriva nei cinema e incassa meno di due milioni di dollari, ma - spiega Smith a chi gli sventola in faccia il flop - facendo la tara fra quei due spiccioli, il budget ridottissimo e i soldi arrivati con gli accordi di distribuzione, chiude in attivo e convince la gente che conta a finanziare non uno, non due, ma addirittura tre nuovi progetti del Kevinone. Nei prossimi anni, quindi, a meno di imprevisti, arriveranno
Clerks 3 e altri due film ispirati al fantastico mondo dei podcast, che comporranno con
Tusk la
True North Trilogy. Tutto è bene quel che finisce bene.
"Stacce."
Ma
Tusk com'è? Beh, è un film che ha per protagonista un podcaster (wink wink) insopportabilmente borioso (Justin Long), amico di un podcaster un po' meno insopportabile ma insomma (Haley Joel Osment). Il borioso, per una serie di incredibili coincidenze nate dallo star cercando argomenti di discussione per il podcast, si ritrova nelle mani di un signore di una certa età (Michael Parks) che, per una serie di eventi che non andremo ad approfondire, non si accontenta di un costume da tricheco. L'inserzione che Justin Long e i suoi baffi scovano è più generica rispetto a quella "reale", offre alloggio gratuito e tante storie interessanti da raccontare, ma il nostro amico Parks è in realtà un pazzo furioso che ha la fissa di trasformare uomini in trichechi. Letteralmente. Justin si ritrova quindi velocemente drogato, senza baffi e vittima di disgustose operazioni che lo trasformano in uno scherzo della natura, una specie di tricheco umano che sbava, ringhia e mangia pesce.
Se sembra una situazione completamente cretina è perché si tratta esattamente di quello. E del resto
Tusk nasce da una chiacchierata scema ed è realizzato a solo uso e consumo di chi voleva il film cretino nato da quella chiacchierata scema. A tutti capita di trascorrere una serata inventandosi idiozie assieme agli amici, buon per Kevin Smith che può permettersi di trasformare quelle idiozie in un film. L'aspetto paradossale della faccenda, per altro, sta nel fatto che
Tusk funziona quando si prende sul serio e crolla miseramente quando la butta in farsa. La parte iniziale, che propone dei protagonisti a metà fra il fesso e il deprecabile e inizia pian piano a costruire il classico viaggio implacabile verso l'incubo, fa il suo dovere. Michael Parks che fa il matto, come già in
Red State, è una meraviglia. Genesis Rodriguez è gnocca. I momenti più puramente horror e di disagio, seppur ovviamente cosparsi da un bel po' di humor nero, funzionano quasi tutti. Insomma, come horror grottesco e completamente sopra le righe,
Tusk non sarebbe neanche male e ti farebbe quasi venir voglia di pensare che abbia cose interessanti da dire sull'attuale era dell'entertainment e della comunicazione online. Quasi, eh.
Il problema è che Smith non sembra interessato a crederci minimamente e butta nel mucchio una deriva demenziale impresentabile, più o meno tutta concentrata nella partecipazione di Johnny Depp truccato da Johnny Depp che fa il cretino canadese con l'accento francese di Johnny Depp e un po' di trucco raffazzonato da Johnny Depp sulla faccia di Johnny Depp. Un personaggio talmente cretino da risultare cretino anche nel contesto di un film cretino come
Tusk, e che - immagino - dovrebbe farci molto ridere perché si capisce benissimo che c'è Johnny Depp sotto quel trucco talmente raffinato da rendere irriconoscibile Johnny Depp. Non ho riso. Sta di fatto, però, che ne viene fuori un film costantemente indeciso fra serietà e farsa, incapace di trovare un equilibrio fra le due direzioni, diretto da una persona a cui, probabilmente, fotte sega. Ciliegina sulla torta, i titoli di coda sono accompagnati dalle porzioni della chiacchierata originale fra Smith e Mosier in cui i due ridono come matti proprio delle parti di storia che il film prova a prendere sul serio. E, insomma, sarà un problema mio, ma faccio proprio fatica a non vederci un'enorme coda di paglia.
L'ho visto al cinema, in lingua originale, qualche tempo fa. Era il film di chiusura del PIFFF 2014. Non so, onestamente, se sia prevista una distribuzione italiana, però è passato al Festival di Roma dell'anno scorso. Fun fact: gli altri due episodi della True North Trilogy
saranno Yoga Hosers
, di cui si sono già concluse le riprese e che è incentrato - glom - sul personaggio di Johnny Depp, e Moose Jaws
, descritto come "Lo squalo
, ma con un'alce". E vabbuò, che gli vuoi dire?